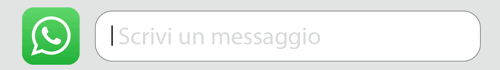Quattro vini sociali per il carcere.
(Il titolo può sembrare volutamente fuorviante. Astenersi se non si è in vena di riflessioni).
In totale contrapposizione con gli slogan nati da una generazione culturalmente educata da Endemol (il vero, il puro, la necessità di gettare la maschera), potrebbe fare la differenza il vestire i panni d’altri. Indossare una moltitudine di maschere. Una formula pirandelliana che ci mostri che faccia ha l’altro. E’ per questo che credo che il teatro vada insegnato nelle scuole: aiuterebbe a guardare la vita da finestre diverse. Anche quando queste hanno le spranghe.

La detenzione è la privazione della vita senza che sopravvenga la morte. Una sorta d’immobilizzazione di un’esistenza che intanto scorre. E’ così. Il carcere è una moltitudine di ossimori: si punisce il furto, privando del tempo il ladro. Una forma di biblico occhio per occhio. Tra i chiosatori seduti ai tavoli dei bar, sento spesso invocare il “carcere duro”, i “lavori forzati”. E mentre si allentano quel nodo troppo stretto di una cravatta portata con lo stesso obbligo di una camicia di forza, proclamano la loro candidatura ad entrare “in galera come vacanza”.
Varrebbe la pena d’intervenire per ricordare ai parolai infuocati di veemenza che, mentre ordinano un caffè-ristretto-macchiato-caldo-con-latte-scremato, di carcere si muore. Dal 2000 al 2017 nelle carceri italiane ci sono stati duemilaseicentosessantacinque morti. Novecentocinquantacinque di questi sono registrati come suicidi. E il numero è in crescita.

Il carcere come forma di reinserimento sociale.
Forse varrebbe la pena spiegare ai branditori del vero assoluto, dagli abiti ingessati e stirati di tutto punto, che in carcere “se vuoi stirarti le mutande devi usare la moka”. E che il carcere è un’istituzione. Come la scuola. E come quest’ultima, dovrebbe riscattare l’individuo, renderlo in grado di interagire con la società e utile agli scopi della comunità.
Dovrebbero essere in grado di comprendere, tra l’ultima birra gelata e un’altra sigaretta, che se in carcere vuoi tenere in fresco qualcosa, devi trovare il modo di rimediare il ghiaccio dalla dispensa e architettare con il tetrapack un contenitore che, solo con un’immaginazione tolkeniana, puoi riuscire a chiamare frigorifero.
Dovrebbero capire che gli errori commessi dai detenuti vanno “aggiustati” e non puniti. Iniziare a riflettere che per ogni soggetto che sbaglia, c’è un mal funzionamento di un’intera comunità. Recepire che l’amputazione non è la guarigione dell’arto, ma la perdita, irrimediabile, dello stesso.
Forse varrebbe la pena di far capire ai cantambanco che brandiscono l’analfabetismo civile in uno shaker di candore e arroganza in stile dadaista, che il carcere non serve a disgregare, ma ad integrare.

“L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare i mondo.
Una volta, nella massima espressione di virtuosismo, si entrava in carcere senza saper né leggere, né scrivere e se ne usciva alfabetizzati, se non addirittura laureati. D’altronde: “L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”, confermava Nelson Mandela.
Oggi, una delle porte attraverso le quali è possibile redimersi, ripristinando dignità e valore al futuro di chi è in carcere, è sicuramente il settore agroalimentare.
Come accade nella Terza Casa Circondariale di Roma Rebibbia, con la panetteria Fine pane mai che lo scorso 20 aprile ha letteralmente aperto un varco tra le mura del carcere. Con questo gioco di parole, che ricorda il fine pena mai, questa panetteria è probabilmente il primo caso in Europa che vede otto detenuti impastare, infornare e sfornare pane di Lariano, pizza e panini, per venderli direttamente fuori dal carcere. Uno dei primi casi in cui sono state smontate quelle architetture mentali che vorrebbero i reclusi isolati da quella società di cui non hanno accetto le regole e dalla quale non sono mai stati accettati.

L’esperienza dei vini sociali in carcere.
L’archetipo di questa forma di resilienza è probabilmente la Casa Circondariale di Velletri. Nel 2003 hanno trovato nuova energia il vigneto e la cantina e, grazie alla cooperativa di detenuti Lazzaria, si è dato vita ad un progetto faticoso ed importante: vendere i vini prodotti dai detenuti fuori dal carcere. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione dell’enologo Sergio De Angelis e dell’agronomo Marco de Biase, che hanno dato respiro a tre etichette dal nome evocativo: Recluso, sia in versione bianca che rossa; Sette Mandate, come quelle che chiudono una cella, e Quarto di Luna, uno Chardonnay in purezza. E se non dovesse essere sufficiente l’etica a convincerci in merito a questi vini, si può sempre ricordare che ne ha espresso pareri lusinghieri anche Veronelli.
Ma se di vini etici si parla, non può essere tralasciata la Falanghina dei Campi Flegrei Selva Lacandona della Cooperativa (R)Esistenza. Questo vino della collina di Chiaiano infatti, oltre ad essere una nobile forma di riscatto e di lavoro per i minori del carcere e i ragazzi a rischio, affiancati dai contadini locali che da sempre lavorano queste campagne, nasce dalle terre confiscate alla Camorra. L’etichetta in maniera briosa suggella con caratteri colorati quale sia la prospettiva della strada intrapresa: “Cooperazione-antimafia-coraggio. Rispetto-beniconfiscati-ambiente. Cambiamento-alternativa-riciclo”.

Camomilla, oliveti bio e mele antiche.
Ma c’è anche l’oliveto bio curato dai ragazzi del Carcere Minorile di Casal del Marmo, vicino Roma, sotto la supervisione di AIAB. Cinquanta olivi impiantati e curati dai giovani ospiti della struttura, che più di ogni altro necessitano di realizzare sulla loro pelle lo spirito riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo del penitenziario. Altra testimonianza in questo senso si è realizzata all’interno del Carcere San Michele di Alessandria, in collaborazione con quello di Biella e Trento. 18 mila ettari di terreni bonificati ed impiantati a frutteto, compresi tre ettari destinati a camomilla. Un progetto promosso da Altromercato e dalla Cooperativa sociale Coompany e finalizzato a coltivare il più grande appezzamento di camomilla in Italia, dopo che il fornitore keniota aveva dato forfait. Nel progetto però anche il recupero di varietà antiche di frutta che rischiavano di scomparire, come la pesca Limunin, tipica del Monferrato e di quei vigneti dove veniva utilizzata come interfilare. O ancora le Pum Marcum e le Pum Dal Medic, antichissime mele piemontesi di cui si è stati in grado di recuperare il patrimonio genetico.

Testimonianze, non certo le uniche, che fanno pensare a come si può edificare un mondo nuovo solo ricostruendo qualcosa di antico.
di Raffaele Marini