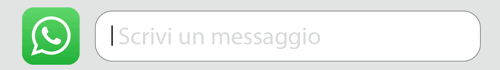Vini vulcanici, vini di Tuscia. Quanti di voi possono dire di conoscerli? “Ti piace il vino?” – “Si!” – “E quale ti piace?”- “Tutto!” – “E allora non ti piace nessuno!”.
Ho deciso di utilizzare questa citazione -di cui non evidenzio gli autori- come entrée del pezzo perché, ad esser cristallini e a voler prendere posizione, va detto che io non amo i vini della mia terra e già fatico nel dovermi legare ad un senso di appartenenza. Quindi, sulle note di Battiato, “… come uno straniero non sento legami…” e iniziamo.
Il Lazio del vino arranca. Ha giocato al ribasso per anni, puntando sulle grandi aziende che hanno industrializzato quello che, secondo natura, è idiosincratico all’addomesticamento da pezzo seriale, sempre uguale, sempre con la stessa patinatura mascherata da “trangugiami senza pensieri”; figlio, quello del Lazio, di un Dioniso democristiano -mi si scusi l’ossimoro religioso- all’ennesima potenza. E la storia ci insegna che tale politica, a lunga gittata, non dona mai grandi risultati.

Ma poi si sa le cose cambiano, si rispolverano gli antichi fasti, quelli etruschi, fescennini e dell’impero romano. Perché di fatto, di popoli legati al vino ne sono passati tanti su questo spartito disgraziato, bagnato dal Tirreno, sostenuto da fondamenta in buona parte vulcaniche, e soffocato tra almeno due grandi regioni, che in termini di viti-vinicoltura hanno fatto e ancora oggi continuano a fare scuola: Campania e Toscana. Inutile nasconderlo: ci è mancato il senso di conservazione, nell’accezione del tutto rivoluzionaria del termine: il Lazio è stato l’epitome di quell’Italia che ogni anno, al momento della vendemmia, in contrapposizione alla Francia, sfoderava la risma del quantitativo e mai del qualitativo. Eppure partendo dal confine a sud e arrivando a quello settentrionale, di aziende che fanno del cupido liquido in maniera seria e devota ce ne sono, e a detta degli esperti, stanno crescendo molto negli ultimi anni.

Vini vulcanici: la Tuscia nel bicchiere
Di certo c’è anche chi il vino buono qui lo ha sempre fatto, di certo non impiantando a casaccio o come il mercato suggeriva; basta guardare ai Castelli Romani, con Colle Picchioni e Casal Pilozzo; o nel Cesanese, con aziende come Damiano Ciolli e La Visciola, rivolte al naturale, che strappano premi importanti e impensabili per un vino così rustico in passato. Nella Tuscia, in provincia di Viterbo, Vignanello ha piccoli fragori di resistenza, in un territorio dilapidato dal “tutto e subito”, con politiche agricole che hanno ottenebrato la vera natura di questo luogo. Eppure in questa eno-trincea, di uomini che si consegnano con produzioni vinicole a dir poco artigianali, ma dalle basi solide, ce ne sono. Forse c’è da raddrizzare il tiro, ma si sa, nel mondo del vino artigianale si fanno gli errori dei poeti, nelle grandi aziende gli errori dei commercialisti. Una menzione di merito va sicuramente a La Quercia, all’Azienda Agricola Minella e a Cantina Valle Maggiore.

Nella parte più a nord, dove l’aria inizia a profumare di Tuscany, ci sono nomi che hanno retto le mode come il Montiano della Falesco: aldilà di ogni opinione non proprio positiva su questo vino -anche un iconoclasta come me l’ha più volte massacrato-, gli va riconosciuto il merito di essere stato l’apripista della Tuscia del vino. Ma nuove realtà ancora nascoste, stanno prendendosi la loro porzione di gloria: Doganieri-Miyazaki con il Confiè Igp Lazio, da uve Montepulciano in purezza, con una vigna di solo un ettaro condotta in agricoltura convenzionale. E’ ancora in Tuscia che risiede uno dei maestri del vino, Sergio Mottura che sforna grechetto dalla risonanza francese: La Tour a Civitella, che sembra essere passato nelle barrique di un’azienda d’oltralpe, è “il primo vino bianco nella storia del Lazio ad ottenere il riconoscimento dei 3 Bicchieri nella Guida ai Vini d’Italia di Slow Food e Gambero Rosso”; e proprio quest’ultima lo sacralizzerà come “uno dei più grandi bianchi d’Italia”. Sono terre vulcaniche, terre da vini vulcanici… vini difficili ma dal grande potenziale.

Ari-sorry al compagno gambero e alla flemmatica chiocciola, il mio preferito di questa realtà è il Poggio della Costa -anche qui non mancano premi-: è edonismo sfrenato il mio a favore dell’acidità non attenuata dalla barrique, ma mantenuta integra dalla vinificazione in acciaio. Ma non si può concludere un pezzo così non citando Gradoli, terra di Aleatico, soprattutto passito, che negli ultimi anni, grazie a micro realtà, sembra aver puntato lo sguardo al naturale di qualità! Tre nomi su tutti: Le Coste di Clementine e Gian Marco, l’Azienda Agricola Georgea Marini, dell’omonima produttrice e Andrea Occhipinti: tutti e tre sfornano vini altamente terragni, antitetici all’anoressia apportata dall’industria; piacevolmente ossidati i bianchi, figli dell’atavica pratica della macerazione sulle bucce, di fresca persistenza i rossi. Tutti i vini avvengono spontaneamente, da fermentazioni autogestite senza inoculo di lieviti selezionati.

Ma la parte del leone su questa terra vulcanica e nebbiosa la fa, almeno per fama e per tradizione, l’Aleatico dolce: Zero8 Aleatico Igt lazio Passito 2012 di Georgea Marini (da congiungere in matrimonio con la locale Susianella) ne è forse l’esempio più eclatante. Questo, insieme al Rosso Arcaico Vdt 2014 di Occhipinti, sono stati premiati nell’innovativa e coraggiosa guida stilata da uno dei più importanti uomini del vino che abbiamo sul territorio nazionale: Carlo Zucchetti, l’enogastronomo col cappello, che insieme al lavoro encomiabile di Alessandra di Tommaso, ha portato alla luce questa parte nascosta del territorio laziale con la neonata guida “La Tuscia del Vino”. E ora dovrò pure rinnegare l’idea di non bere i vini di casa mia!
di Raffaele Marini